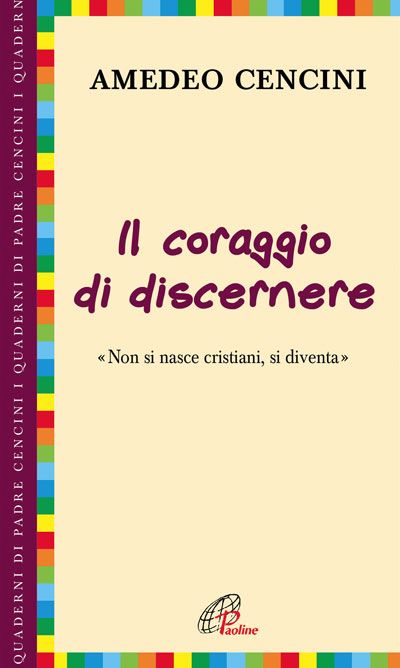Soffrendo insieme
#Fermati e...
Fermati, leggi e pensa... con Amedeo Cencini e prova a dare uno sguardo al tuo e nostro modo di vivere questo tempo. Cosa significa scoprirsi fragili e alle prese con un mostro invisibile? Quali sono le realtà che possono naturalmente scattare in noi? Cosa c'è tra noi? Qual è la "verità" che questo strano difficile momento ci può insegnare?
Alle prese con la paura
È la prima volta. Non abbiamo mai vissuto un'esperienza così destabilizzante. Capace di cambiare i nostri stili di vita dall'oggi al domani, e di convincere un popolo di allegri indisciplinati a darsi regole da osservare insieme.
Alle prese con la paura
Provo a guardare il fenomeno dal punto di vista che mi è più abituale, quello psicologico. E rilevo che all'origine di tutto ciò c'è la paura, la paura della morte. Inutile girarci attorno. È l'istinto di sopravvivenza che si sente aggredito, e aggredito da un nemico invisibile e misterioso, vigliacco perché non si lascia riconoscere. Anzi, viaggia normalmente nascosto in chi ci vive accanto o in coloro con cui entriamo in contatto. Ma nessuno sa di ospitarlo... né può saperlo. Non lo sappiamo neppure di noi stessi.
E questo è quanto potrebbe bastare per ingenerare un sospetto a tappeto e vivere nel panico. È ciò che ci potrebbe far allontanare da tutti e potrebbe distruggere i rapporti.
Eppure non è quello che stiamo vedendo attorno a noi. Al contrario. Non ci siamo mai sentiti così tanto popolo e nazione; nascono un po' ovunque manifestazioni spontanee di solidarietà e condivisione, che dicono la voglia, nonostante tutto – e pur con le restrizioni del momento –, di trovarsi, aggregarsi, vivere insieme questo momento difficile, diffondendo messaggi di speranza e ottimismo. Siamo costretti a vivere nelle nostre case, e così stiamo riscoprendo l'uso del balcone come moderno luogo e strumento di comunicazione, che ci mette in contatto con gli altri, per cantare, continuare a sorriderci, e scoprirci uniti come non lo siamo mai stati. Il cuore trema, ma sappiamo fare ironia anche su quel virus che lo fa tremare...
E il sospetto sta diventando il suo contrario
La paura dell'altro come portatore di morte s'è trasformata in bisogno e ricerca dell'altro come compagno indispensabile in questo tratto impervio di vita. Lontani e così vicini; soli, eppur nessuno si sente solo; ci si dice giustamente di evitare assembramenti, e mai come in questi giorni abbiamo cercato il contatto e goduto di sentirci comunque in relazione, in ogni caso "insieme".
Ci sentiamo impotenti di fronte alla morte, eppure – mentre salgono e scendono impietosi i numeri di contagi e vittime in Italia e nel mondo – ci ripetiamo con insistenza: "andrà tutto bene", "ce la faremo anche stavolta"...
Siamo diventati tutti supersalutisti e ossessionati del nostro individualissimo benessere, ma mai come in questi giorni abbiamo capito che la salute è bene comune, che la mia salute dipende dalla tua, che o stiamo bene tutti insieme, compresa la terra che calpestiamo, o nessuno sta bene, nemmeno l'aria che respiriamo.
Sono solo alcune delle lezioni che stiamo imparando da questo dramma.
Ma ce n'è un'altra, immensa: gli eventi catastrofici tirano fuori dall'umanità il meglio, anzi, la sofferenza vissuta assieme ha questo potere veritativo, perché ci fa sentire più vicini al senso normale delle cose e di se stessi, della vita e dell'altro (A.Romagnoli).
In tempi tranquilli si soffre da soli, vergognosi e risentiti verso chi sta bene. Il disastro generale, invece, pone tutti sullo stesso piano e abbatte ogni divisione e competizione, rende tutti più pensosi e attenti a quel che siamo, più veri e dunque anche più buoni. Ovvero, la bontà è la verità e la normalità di quel che siamo. Però questo, diceva Quarantelli, «è difficile da accettare, è una verità troppo rassicurante».
Ma lo diceva in tempi tranquilli, quando non c'era una domanda forte di verità.
Oggi, noi, in tempi difficili, proprio questa è verità che stiamo (ri)scoprendo.